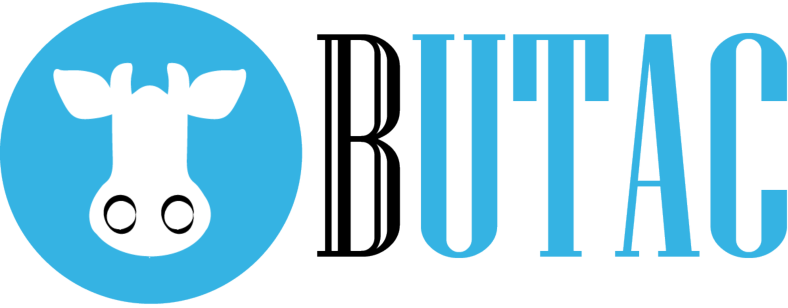Report e l’Internazionale: COVID-19 colpa degli allevamenti intensivi?
Nella puntata del 13 aprile di Report si trattano parecchi argomenti. Due servizi in particolare meritano un po’ della nostra attenzione.
A partire dal minuto 23 inizia la parte del programma “Siamo nella cacca”. Molte delle cose che vengono dette sono giuste e assolutamente condivisibili. Il succo del discorso, come dice il titolo, è che siamo nella cacca. A mio avviso in tutti i sensi, ma è una mia personalissima opinione.
Siamo nella cacca
Il primo servizio parla sostanzialmente di inquinamento, inquinamento causato dai liquami prodotti dagli allevamenti intensivi di bovini, suini e pollame. Questi liquami, se non trattati adeguatamente, causano inquinamento delle falde acquifere e anche dell’atmosfera. Chiederete, giustamente, ma a parte la puzza come fanno a causare inquinamento atmosferico? Il processo è molto semplice e il composto “incriminato” è l’ammoniaca. I liquami e il letame generato dagli allevamenti vengono raccolti e poi utilizzati come concime. Non appena i concimi vengono distribuiti sul terreno sono a diretto contatto con l’aria e una parte dell’ammoniaca presente nel concime fuoriesce. Successivamente dall’ammonio presente nel concime viene riprodotta ammoniaca, che a sua volta si libera nell’atmosfera. Lo spargimento dei concimi sul terreno, le temperature e il vento sono fattori determinanti per le perdite di azoto: quanto più lungo è il periodo di spargimento del liquame o del letame e più elevate sono le temperature e la velocità del vento, maggiori saranno le perdite di ammoniaca. Senza considerare ovviamente la dispersione di ammoniaca che si ha durante lo stoccaggio del concime. Fin qui, giornalisticamente parlando, tutto bene.
L’idea di partenza del servizio è giusta:
…sensibilizzare il consumatore affinché si renda conto dell’impatto ambientale che ha ogni sua scelta alimentare. Ma i giornalisti di Report hanno dovuto inserire anche dei riferimenti alla Covid-19. Ma perché, mi chiedo, rovinare un servizio infilandoci la Covid-19? Perché fa figo e in questo momento fa anche audience. Bene, ma se fa figo allora dipaniamola bene questa matassa, entriamo più nel dettaglio. Peccato che più di tanto nel dettaglio non si possa entrare. Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati studi sul PM10 e sul PM2.5 come vettori che riescono a trasportare i virus a più lunga distanza. In questo paper, oltre a trovare anche una discreta biografia di studi effettuati, si avanza l’ipotesi di una correlazione tra i superamenti dei limiti per il PM10 in alcune città e il numero di ricoveri da Covid–19. Si tratta di un’ipotesi da verificare anche perché basata su un numero assai limitato di osservazioni. Il documento conclude che
CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI
Si evidenzia come la specificità della velocità di incremento dei casi di contagio che ha interessato in particolare alcune zone del Nord Italia potrebbe essere legata alle condizioni di inquinamento da particolato atmosferico che ha esercitato un’azione di carrier e di boost. Come già riportato in casi precedenti di elevata diffusione di infezione virale in relazione ad elevati livelli di contaminazione da particolato atmosferico, si suggerisce di tenere conto di questo contributo sollecitando misure restrittive di contenimento dell’inquinamento.
Certo nel servizio di Report si fa notare tutto ciò, ma lo spazio generale che si dedica alla questione è limitato. Il risultato è che adesso la gente incolperà gli allevamenti della pianura padana per la diffusione della Covid-19 in Lombardia.
Si butta la pietra nello stagno e si ritrae la mano guardando i cerchi concentrici che si espandono nell’acqua.
Buttata la pietra si passa subito agli allevamenti in Valtellina (ma come… non si era detto poco fa che allevamenti “bucolici” come quelli delle pubblicità non esistono?). Il collegamento con la Covid-19 non viene menzionato nel servizio, anche se verso la fine viene detto che deforestando la possibilità di spill-over da parte dei virus aumenta. No, fermi un momento, cosa c’entra la deforestazione con tutto questo? Semplice… è tutta colpa della bresaola. Tutti vogliono la bresaola della Valtellina e non ci sono abbastanza capi per soddisfare la richiesta nazionale e internazionale. E allora una delle più grandi ditte produttrici di bresaola, comprata proprio da una società brasiliana, cosa fa? Usa un animale “mitologico” per produrla. Mitologico perché stando alle dichiarazioni del presidente di Coldiretti, l’animale che viene utilizzato è più simile a una zebra incrociata con un cammello, lo zebù che, sempre secondo lui, non appartiene assolutamente alla famiglia dei bovini. Secondo il presidente di Coldiretti quindi questa ditta produce e immette sul mercato una bresaola della Valtellina IGP fregandosene del disciplinare:
La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell’età compresa fra i 18 mesi e i quattro anni.
E non fa niente. Andiamo bene eh. Ma Report forse non sa quanto dichiarò questa azienda nel 2017. Vi lascio qui il link all’articolo apparso all’epoca su Repubblica e sul Fatto alimentare, ma sono sicura ce se cercate ne trovate altri anche voi.
Ma alla fine la Covid-19???
Verso la fine del servizio, che si addentra anche nel mondo brasiliano della deforestazione, intravediamo una breve intervista a un ricercatore della Sapienza di Roma che “studia gli effetti del cambiamento legati alla diffusione di pandemie, e uno dei fattori chiave è la deforestazione in zone tropicali”. Due minuti, secondo più secondo meno, per spiegare l’aumento della probabilità di spill-over. Mi pare un po’ poco. Ma lascio giudicare a voi.
Sarà anche cambiata la conduzione di Report ma non mi sembra sia cambiato il taglio della trasmissione. Questo servizio sembrava più un attacco alla ditta che produce bresaole che altro. Prova ne è il fatto che mentre scrivevo l’articolo, andando in cerca del disciplinare, ho scritto su Google “bresaola” e il primo suggerimento che mi appare è “bresaola nome della ditta zebù”. Et voilà, il danno d’immagine è fatto.
L’Internazionale
Comunque anche questo articolo, comparso sul sito de “L’Internazionale” l’8 aprile, non scherza in quanto a correlazioni tra pandemia e allevamento intensivo. Ecco un buon esempio di come non fare giornalismo, a mio avviso.
L’articolo parte bene, si pone delle domande, più che legittime in questo particolare periodo. Parte bene e finisce anche bene, proponendoci degli spunti di riflessione. È quello che c’è in mezzo che non va.
L’autrice si pone sin da subito una serie di domande:
C’è una relazione tra allevamenti intensivi e nuovo coronavirus? Da dove proviene il virus responsabile dell’attuale pandemia? Com’è arrivato nel mercato cinese di Wuhan da dove si pensa sia passato agli esseri umani?
Le risposte che emergono non raccontano, come si sostiene, una scomoda verità. Raccontano una possibile verità. Tutti noi siamo ancora ben lontani dal poter affermare con assoluta certezza quello che – perdonatemi l’assoluta scorrettezza della frase ma rende bene l’idea – “passa per la testa di un virus”. Visto il taglio iniziale dell’articolo, con tante domande, non ci si può soffermare principalmente su una delle teorie possibili solo perché è quella che ci ispira di più, o che conferma le nostre convinzioni che le multinazionali del cibo siano il male. Purtroppo è ciò che ha fatto la giornalista del Guardian, dare maggior risalto a una sola tesi: nonostante nel suo articolo citi anche chi propone teorie alternative e/o complementari, il pensiero del professor Rob Wallace espresso nel libro “Big farms make big flu” ha il ruolo di primo attore.
In questo periodo di quarantena, nonostante sia una delle fortunate che ha la possibilità di lavorare da casa, ho più tempo libero che non dedico assolutamente ai lavori di casa o al giardinaggio, così ho approfondito un po’ la questione, leggendo articoli su articoli.
La questione è controversa. A mio avviso non vi è un solo attore principale, le multinazionali del cibo con la loro brama di profitti, gli allevamenti e l’agricoltura intensiva. Entrano in questa grande pièce anche i consumatori e le dinamiche consumistiche, e i Paesi in forte crescita come la Cina.
Vi riporto, come esempio alcuni passaggi.
Se è vero che:
La trasformazione economica della Cina, cominciata negli anni novanta, ha coinvolto anche la produzione alimentare portandola a livelli industriali. Come documentato dagli antropologi Lyle Fearnley e Christos Lynteris, un effetto collaterale è stato l’estromissione dei piccoli allevatori, alcuni dei quali hanno trovato nell’allevamento di specie “selvatiche” – un tempo semplice cibo di sussistenza – una nuova fonte di reddito.
Non è corretto quanto segue:
Il settore è stato ufficializzato e i suoi prodotti sono stati considerati sempre più di lusso. I piccoli allevatori, però, non sono stati estromessi solo in senso economico: a mano a mano che gli allevamenti intensivi occupavano più terra, sono stati estromessi anche in senso fisico e spinti verso zone incoltivabili, cioè verso il limitare della foresta dove si aggirano i pipistrelli e i virus che li infettano. La quantità e la frequenza dei contatti in questa prima interazione sono aumentate insieme al rischio del salto di specie.
Perché gli stessi antropologi Lyle Fearnley e Christos Lynteris affermano proprio nell’articolo citato dalla giornalista del Guardian (citazioni tradotte):
È seguito un enorme consolidamento, poiché i piccoli proprietari indipendenti sono stati progressivamente espulsi dall’allevamento, in particolare in settori come il maiale o il pollame, perché i prezzi sono scesi troppo e il costo degli input è aumentato. Anche le malattie del bestiame, come la malattia di Newcastle e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini, hanno svolto un ruolo nel condurre i piccoli proprietari di animali in questi settori. Incapaci di sopravvivere come piccoli proprietari indipendenti, molti allevatori affrontarono una scelta drastica: intraprendere l’agricoltura sotto contratto con un conglomerato alimentare industriale o abbandonare del tutto l’allevamento suino o del pollame.
Alcuni allevatori hanno scoperto un terzo modo, optando per l’allevamento di razze locali e animali selvatici che potrebbero essere venduti per rendimenti più elevati nei mercati di nicchia. Molte di queste specie erano meno affette da malattie rispetto al bestiame tradizionale, spesso semplicemente un effetto del numero minore di allevamenti.
L’articolo citato dalla giornalista quindi non conferma quanto da lei affermato. Anzi, uno degli articoli citati dai due antropologi e scritto dallo stesso Fearnley giunge a conclusioni opposte: sarebbe stato proprio l’allevamento all’aperto e allo stato libero delle anatre ad aver dato la possibilità ad alcuni virus influenzali di effettuare il salto di specie. L’articolo di Lyle Fearnley è molto lungo e anche abbastanza complesso, ma merita di essere letto.
Perché poi citare virus come ebola o HIV? Sono virus completamente diversi dai coronavirus. Ebola appartiene alla famiglia dei Filoviridae ed è stata scoperta nel Sudan del sud nel 1976. Il Sudan ha (dati 2016) una popolazione di 40 milioni scarsi di abitanti, poco più di 16 per kmq. HIV invece appartiene alla famiglia dei Lentivirus, di origine africana anche questa.
Tutto il resto dell’articolo della giornalista del Guardian è una continua smentita delle teorie “alternative” a quelle proposte da Wallace. Si arriva a fine lettura con la sensazione che la colpa di tutto ciò sia solo ed esclusivamente delle “big farms”.
Se da un lato è vero che certe dinamiche consumistiche debbano essere riviste, perché causano l’assottigliamento della superficie mondiale di aree naturali necessarie alla fauna selvatica, dall’altro gli allevamenti offrono garanzie di sicurezza igienica maggiore: maggiori controlli da parte dei veterinari e delle autorità non solo nel mondo occidentale ma anche in quello orientale, sviluppo di vaccini da somministrare “in ovo” cioè ai pulcini non ancora nati, maggiore attenzione al benessere animale, minore o nessuna somministrazione di farmaci grazie a pratiche di allevamento che mettono al primo posto proprio il benessere degli animali, selezione di razze a crescita più lenta e meno soggette a malattie. Il tutto perché il benessere animale, anche e soprattutto degli animali da reddito, è una tematica sempre più presente sugli scaffali dei supermercati, indice di una maggior consapevolezza da parte dei consumatori. Perché diciamocelo, è anche colpa di noi consumatori se le grandi multinazionali dell’allevamento e dell’agricoltura hanno puntato tutto sulla quantità e non sulla qualità. Noi consumatori siamo delle “bestie strane”, e se ci ragionate sopra un momento anche voi, vi accorgerete che non c’è bisogno che vi faccia un elenco del perché.
Sicuramente la fine dell’articolo è davvero condivisibile, a prescindere da tutto quanto è stato scritto scritto prima:
Secondo lui (Wallace) ci viene offerta l’occasione di analizzare il nostro stile di vita – perché se il pollo costa un milione di vite umane non è a buon mercato – ed eleggere politici che impongano al settore agroindustriale standard di sostenibilità ecologica, sociale ed epidemiologica più alti. “Con un po’ di fortuna”, dice, “cambieremo le nostre pratiche di produzione agricola, utilizzo del suolo e conservazione”.
Thunderstruck @ butac . it
Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!