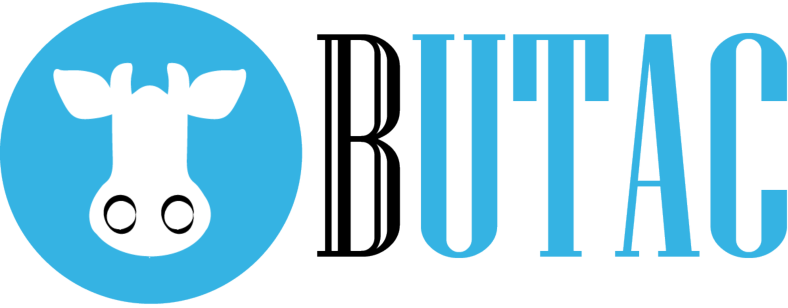Buste biodegradabili e studi scientifici

Quante volte ci capita di leggere articoli di stampo allarmistico, apparentemente basati su una legittima ricerca scientifica? Purtroppo la storia si ripete anche in questo caso. Dico “purtroppo” perché l’articolo viene da una rivista che si dichiara di essere “dalla parte del cittadino” e di essere “leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori”.
Parliamo dell’articolo:
“Buste biodegradabili? Solo a parole: dopo 3 anni sono ancora intatte”
Apparso sul sito web de “il Salvagente” in data 29 aprile 2019, a firma di Enrico Cinotti, il vicedirettore.
L’articolo mi ha subito colpito (positivamente) perché assolutamente verosimile: per esperienza nel settore conosco diverse formulazioni pensate per essere “biodegradabili” che purtroppo si sono rivelate molto più ostiche da smaltire del previsto. Il problema è che quando sono andato a cercare la fonte originale, ho scoperto che i contenuti erano stati travisati.
Prima di proseguire permettetemi di aggiungere una cosa: mettere un chiaro rimando alle fonti, un link o una nota bibliografica, è un segno di professionalità. Quando questi rimandi “diretti” mancano, deve sempre venirvi il dubbio che i contenuti siano in qualche modo stati “interpretati”. Più inaccessibile è una fonte, più è probabile che sia stata distorta dall’autore.
La ricerca originale
La ricerca originale su cui si basa l’articolo de “il Salvagente” è “Environmental Deterioration of Biodegradable, Oxo-biodegradable, Compostable, and Conventional Plastic Carrier Bags in the Sea, Soil, and Open-Air Over a 3‑Year Period”, pubblicato da E. Napper e R.C. Thompson su “Environmental Science & Technology” dell’ACS (American Chemical Society). L’articolo è dietro pay-wall, come spesso capita, ma fortunatamente la mia università fornisce accesso a questi documenti. Se qualcuno volesse avere una copia di questo interessante lavoro, può comunque contattare direttamente l’autrice al suo indirizzo email istituzionale, l’ACS autorizza gli autori a distribuire copie, purché non nell’ultima revisione. Al limite contattate pure me che vi do una mano volentieri.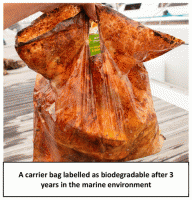
Gli autori hanno confrontato cinque tipi di buste di plastica commerciali, esponendole a tre diversi ambienti: aria aperta, sotterrate e immerse in acqua di mare. I risultati sono stati poi confrontati con dei campioni di riferimento tenuti in laboratorio. Le buste erano di materiali oxo-biodegradabili, biodegradabili, compostabili e “inerti”. Cosa significhino questi termini “il Salvagente” purtroppo non ce lo spiega, ma certo contribuisce a rendere più allarmistico il tono generale dell’articolo. Bisogna innanzitutto capire che le materie plastiche sono costantemente in mutamento, diversamente da ceramici e metalli sono generalmente molto più sensibili alle condizioni ambientali e soggetti a costanti reazioni chimico-fisiche che vanno dall’ossidazione (o foto-ossidazione) al cross-linking, dalla formazione di radicali alla transizione vetrosa. Per farla breve, una materia plastica è in costante (più o meno rapida) evoluzione.
Ma perché le buste biodegradabili che siamo abituati ad usare sono così poco performanti rispetto a quelle convenzionali? La risposta è molto semplice: è una coperta corta. Le stesse caratteristiche chimiche che aumentano le proprietà meccaniche sono responsabili della scarsa biodegradabilità.
Esistono poi diversi modi di “distruggere” una materia plastica, da cui i diversi nomi dati ai materiali. “Biodegradabile” fa riferimento al fatto che può essere dissolto da processi enzimatici (batteri, funghi o altri microorganismi), anche se il significato è stato esteso anche ad altri agenti fisici naturali come la luce solare o l’acqua. “Compostabile” fa riferimento al fatto che il processo di decomposizione sia in grado di avvenire in meno di 3 (6) mesi. Per ulteriori chiarimenti in merito potete leggere la norma europea EN 13432 del 2002 che fornisce tutte le caratteristiche con maggior dettaglio. “Oxo-biodegradabile” è una definizione piuttosto recente: si tratta di plastiche che contengono additivi che ne velocizzano la frammentazione in particelle minuscole se esposti a radiazione ultravioletta o al calore. Il problema è che ad oggi molte plastiche oxo-biodegradabili non hanno dimostrato di essere biodegradabili generando frammenti sostanzialmente inerti.
L’analisi dell’articolo su il Salvagente
Enrico Cinotti scrive:
“Il sacchetto della spesa biodegradabile? Non proprio visto che dopo 27 mesi (come mostra la foto in alto) passati sotto terra e in ambiente marino è ancora intatta, in grado di essere usata per fare acquisti. È questo il risultato dell’esperimento condotto dai ricercatori dell’Università di Plymouth, l’International Marine Litter Research Unit, e pubblicata sulla rivista Environmental Science and Technology, che hanno messo alla prova cinque diversi tipi di sacchetti: due tipi di buste oxo-biodegradabili, una borsa biodegradabile, una borsa compostabile e una busta in polietilene ad alta densità, un sacchetto di plastica convenzionale.”
L’articolo si apre con un piccolo strafalcione. Il sacchetto (entrambi i sacchetti, nell’articolo originale) è oxo-biodegradabile e non biodegradabile. E, come da definizione, richiede di essere esposto a fonti di calore o radiazione ultravioletta per essere in qualche modo “frammentato”. Sia nella prova di immersione in acqua marina (del Regno Unito) che nel caso del campione interrato, si è tolto al campione l’accesso a quella fonte di energia necessaria ad iniziare il processo di smaltimento. Purtroppo il risultato non è che quello che avremmo dovuto aspettarci: gli oxo-biodegradabili hanno performance meccaniche piuttosto buone il che significa (per la questione coperta corta di cui sopra) che non sono facilmente biodegradabili.
“I risultati sono stati davvero sorprendenti: dopo 27 mesi nessun prodotto, proprio come la plastica tradizionale messa al bando da anni nei sacchetti per la spesa, si era “degradato” nell’ambiente o nell’acqua marina. Imogen Napper, ha guidato lo studio e ha dichiarato: “Dopo tre anni, sono rimasto davvero sorpreso dal fatto che una delle borse addirittura potesse ancora contenere un carico di spesa. La performance delle borse biodegradabili è stata la più sorprendente. Quando leggiamo biodegradabile, pensiamo giustamente che si degraderà più rapidamente delle borse convenzionali. Ma, dopo almeno tre anni, come mostra la nostra ricerca, ciò non avviene“.”
A parte il fatto che Imogen Napper è una donna, come sarebbe stato immediatamente chiaro facendo una semplice ricerca su Google (https://www.nationalgeographic.org/find-explorers/imogen-e-napper), la busta compostabile si era completamente dissolta in acqua marina, in tre mesi, mentre tutte le buste si sono ridotte in frammenti entro nove mesi di esposizione all’aria (che, ricordiamolo, è quanto richiesto dalle buste oxo-biodegradabili), quindi c’è stata degradazione per tutti i campioni in almeno un ambiente. Che, chiariamolo subito, è ben lontano da essere un traguardo encomiabile.
Quello che mi era inizialmente sfuggito è un dettaglio riguardante la busta biodegradabile, quella che ha dato i risultati più “sorprendenti” secondo l’autrice. Il dettaglio è che il materiale è degradabile secondo la normativa ISO 14855 (di cui potete vedere una preview gratuita qui (https://www.sis.se/api/document/preview/906535/) e che si riferisce ad ambiente aerobico. Quindi non marino e non interrato nel suolo, solo esposto all’aria.
“Il professor Richard Thompson, a capo dell’Unità, ha aggiunto: “Dimostriamo con questa ricerca che i materiali testati non presentavano nessun vantaggio consistente, affidabile e rilevante nel contesto dei rifiuti marini. Il nostro studio sottolinea la necessità di standard relativi ai materiali degradabili, delineando chiaramente il percorso di smaltimento appropriato e i tassi di degrado che possono essere previsti”.”
Questo è tragicamente vero. L’idea che abbiamo in testa di “degradabilità” è differente da quanto è stato effettivamente normato e spesso le condizioni in cui sono stati effettuati i test sono poco rappresentative di alcuni ambienti reali. Gli standard comunque esistono, si tratta più che altro di essere più chiari verso l’utilizzatore e fornirgli i mezzi per capire come deve comportarsi con il rifiuto.
Dopo aver letto le dichiarazioni personali degli autori riportate, ho avuto l’impressione che Enrico Cinotti abbia basato il suo articolo su una forse affrettata traduzione dell’articolo uscito sul sito del National Geographic (https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/04/biodegradable-shopping-bags-buried-for-three-years-dont-degrade/). Ed è un peccato, perché c’è molto di più da dire sull’articolo originale e l’articolo de “il Salvagente” ha creato l’ennesimo pretesto
Il “Sole 24 Ore” è il primo a riportare una nota di Assoplastiche, l’”associazione italiana dei produttori di bioplastiche” (https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-04-29/plastica-e-ambiente-amara-sorpresa-sacchetti-biodegradabili-non-si-dissolvono-170923.shtml?uuid=ABbrNmsB) che tenta di correggere l’intepretazione errata dello studio diffusa poi da diverse testate. Riporto la parte a mio avviso più importante dell’intervento:
“La biodegradabilità insomma, come lo studio lascia presumere, non deve essere mai vista come una più comoda soluzione o una scusa per la disseminazione incontrollata nell’ambiente (che porterebbe al paradosso di legittimare ad esempio il littering degli scarti e residui organici in mare, in quanto biodegradabili).”
Non bisogna quindi rovesciare il ruolo dell’utilizzatore del prodotto: se la raccolta e lo smaltimento vengono svolti correttamente allora e solo allora possiamo effettivamente vedere avvenire la biodegradazione di questi materiali.
Note aggiuntive per scientisti pedanti
Dal punto di vista scientifico, il lavoro ha diverse pecche che lo rendono effettivamente meno interessante rispetto al suo invece evidente impatto sociale. Cercherò di riassumere brevemente di seguito quelle che mi hanno colpito di più:
- Nonostante si tratti di materiali di facile reperimento, sono stati studiati solamente cinque tipi di campione. Questa è una pecca gigantesca, soprattutto considerando che vi è un solo tipo di prodotto per la maggior parte delle categorie. Sappiamo quindi come si comporta quella specifica borsa di quella altrettanto specifica marca ma non sappiamo quanto i risultati siano rappresentativi. Questo è giustificato per materiali costosi (mi vengono in mente i polietileni ad altissimo peso molecolare usati in campo biomedicale), non per delle buste di valore commerciale prossimo allo zero. La giustificazione che “erano facilmente reperibili a Plymouth e dintorni” poi è un brutto campanello d’allarme su come è stato condotto lo studio;
- Il protocollo usato per ottenere i campioni è… inusuale. Si parla di massimo due borse acquisite per ogni visita al negozio, con un intervallo di almeno due settimane tra le visite. Questo significa che per ottenere tutte e 16 le borse dichiarate sono stati necessarie 8 settimane e visite a (fino a) cinque differenti negozi. Sembra più una serie di eventi occasionali, quasi fosse il normale shopping al negozio. Ma in quel caso, le borse “usate” sarebbero state già sottoposte ad una prova meccanica non presentata nella lista. Nulla ci è dato sapere di come siano state conservate le borse che “aspettavano” da due mesi:
- Non c’è alcuna indagine sulla composizione chimica dei materiali. Si sa che una è di polietilene ad alto peso molecolare, delle altre non c’è informazione. Si dice nella descrizione sperimentale che è stato effettuato dell’FT-IR e che i risultati sono stati confrontati con il database dei polimeri sintetici, ma non sono fornite ulteriori informazioni, il tutto è liquidato in sette righe dove si parla di una piccola banda apparsa a 1715 cm-1, ma parliamo di 5 materiali diversi in 3 condizioni di studio e chi conosce l’FT-IR sa benissimo che qualcosa non quadra, c’è sicuramente molto di più da dire. Ci sono poi numerose tecniche necessarie (ripeto, necessarie, non opzionali) per caratterizzare un polimero che degrada nel tempo, tecniche che ci avrebbero dato dei dati su cosa stesse avvenendo nelle diverse condizioni, ma lo studio non le menziona. In questo modo non sappiamo nulla di cosa avvenga a livello molecolare;
- Si parla di analisi al microscopio elettronico, ma l’articolo principale non mostra nulla di simile e nelle supplementary informations vengono mostrati solo due campioni su cinque, in due sole condizioni, ad un solo ingrandimento che poco o niente ci dice sul meccanismo di degrado;
- La statistica è molto debole. Si sono fatte solo 4 prove meccaniche per campione. Chi si occupa di polimeri biodegradabili sa che questo non è sufficiente. Sullo spessore, la misura non presenta deviazione standard. Questo indica che è stato probabilmente utilizzato un metodo non sufficientemente preciso, che ha quindi inficiato anche la misura della resistenza meccanica;
bonus finale
Il claim di Thompson: “we are confident in the work, as we have been all along and it’s been through full peer review” (siamo fiduciosi riguardo al lavoro, come lo siamo sempre stati, ed è stato sottoposto a una completa peer review) è un pessimo esempio di overconfidence, eccessiva presunzione. Qualunque scienziato abbia un po’ di dimestichezza con i materiali polimerici troverebbe i primi cinque punti sufficienti ad inficiare il significato del lavoro.
Elia Marin
Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su Paypal! Può bastare anche il costo di un caffè, volevo mettere un sacchetto biodegradabile, ma quelli costano davvero poco…