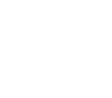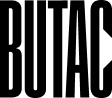Preparazione civile, prospettive e futuro
Un editoriale sulla tendenza tutta italiana a confondere "preparazione" e "allarmismo"

Ho figli che vivono in Stati diversi dell’Unione Europea. Ho un background militare ma senza alcuna voglia di morire in battaglia, né che altri debbano farlo. Vivo a Bruxelles e da anni tengo uno zaino pronto in caso di emergenza. Un prepper nato o forse NATO…
Chi scrive queste parole non è un allarmista, non è un complottista, e nemmeno uno che sogna scenari apocalittici. Con queste parole (lievemente modificate per rispettare la privacy di chi ce le ha scritte) si apre la mail di un amico di BUTAC, cittadino europeo, che ha voluto condividere con noi una sua riflessione. Riflessione che ha generato l’editoriale che state per leggere.
Sono tanti i Paesi europei che negli ultimi mesi, o anni, hanno pubblicato e aggiornato manuali dedicati alle possibili emergenze. L’Estonia ha diffuso un suo rapporto sulla sicurezza internazionale, la Polonia ha distribuito un opuscolo su come affrontare situazioni di crisi, in Francia si discute su cosa debba essere incluso in un kit di sopravvivenza. Nei Paesi nordici è assolutamente normale essere pronti a ogni evenienza. Non si tratta di documenti allarmistici che prevedono che scoppierà una guerra di qui a breve, ma di documenti che parlano di emergenze in senso più ampio: guerre sì, ma anche blackout prolungati, attacchi informatici, calamità naturali. Quello che emerge è che tante realtà europee stanno investendo nella preparazione civile.
L’Italia, pur essendo un Paese che avrebbe tanti motivi per cercare di informare la popolazione su possibili emergenze – da quelle climatiche (vedi ad esempio quanto successo col ciclone Harry) agli eventi straordinari come i terremoti fino appunto a casi come i già menzionati blackout prolungati o gli attacchi informatici – in merito fa davvero poco. Anzi, a voler essere onesti in Italia i libretti per le emergenze che vediamo distribuiti negli altri Paesi vengono considerati allarmismo senza motivo di esistere. Non solo dalla normale popolazione, ma anche da chi dovrebbe informare. Su tanti media nazionali le iniziative in tal senso difatti vengono raccontate con toni che oscillano tra l’ironia e lo scetticismo. Perché succede questo? Perché dobbiamo trattare le iniziative di Paesi vicini come se fossero eccezioni folkloristiche che non ci dovrebbero preoccupare in alcun modo, quando l’eccezione folkloristica siamo noi?
Il nostro Paese ha una lunga tradizione della gestione emergenze, ma quasi sempre nel “dopo”. Dopo che c’è stato un terremoto, un’alluvione, una pandemia, la nostra risposta operativa c’è, spesso funziona, è efficace quando necessario, ma appunto dopo. La cultura del “prima”, della preparazione sistemica, non ci appartiene davvero. E questo sta diventando un problema. Non serve evocare scenari di guerra per rendersene conto: il futuro è già fatto di emergenze climatiche, di eventi estremi e di vulnerabilità infrastrutturali. In Italia il dissesto idrogeologico è strutturale, e la prevenzione resta spesso insufficiente o frammentata. Che esistano o meno segnali evidenti prima di un evento, il tema della pianificazione e della riduzione del rischio resta tanto centrale quanto trascurato.
Prepararsi, nel nostro contesto culturale, viene percepito come un’inutile evocazione del peggio. Siamo superstiziosi: preferiamo convincerci che certi scenari non accadranno mai. Lo abbiamo visto anche quando abbiamo scritto dei Campi Flegrei: nei commenti si scatenarono le accuse di allarmismo, come se parlare di rischio equivalesse a volerlo.
L’Unione Europea dovrebbe servire anche a questo, a superare la nostra carenza di preparazione e traghettarci verso un futuro fatto di cittadini che sanno cosa fare in caso d’emergenza. E invece l’UE viene vista come la cattiva di cui non fidarsi, e la percezione italiana è tutta nazionale. Come se non fossimo tutti parte di un unico progetto.
C’è un passaggio nella mail che ci è stata inviata che mi ha colpito molto:
Quando ho chiesto la carta d’identità belga, nello spazio della firma era indicato “firma del cittadino dell’Unione Europea”. Non vi nascondo di essermi commosso.
Ecco, anche io mi sarei commosso, perché è questo che mi sento: cittadino europeo. Con la percezione di appartenere a qualcosa che esce dai confini nazionali, più grande del singolo Stato in cui sono nato. Ecco, io credo che culturalmente sia giunto il momento di fare quel passo, di sentirci sempre più parte di questo qualcosa, e cercare, insieme di fare dei passi verso un solo grande Paese, diviso da diversità regionali, certo, ma unito nelle cose concrete. E una di queste, urgente, è appunto quella che riguarda l’essere preparati, per affrontare, insieme, le possibili emergenze che ci si pareranno di fronte nei prossimi anni. Riconoscere che le emergenze non saranno loro o nostre, ma comuni, da affrontare insieme.
Prepararsi non significa desiderare che succedano brutte cose, non significa volere che succedano; prepararsi vuol dire riconoscere che non possiamo prevedere cosa ci riserva il futuro. Farlo, senza allarmismi sciocchi, dovrebbe essere una responsabilità che riguarda tutti, a partire dalle istituzioni fino ad arrivare a noi cittadini.
C’è infine un altro tema che ha toccato il mittente della mail, vivendo e frequentando altri Paesi europei: il modo con cui viene affrontato il tema dell’information disorder, più comunemente chiamato “problema delle fake news”. Perché fuori dai confini nazionali sono tanti i Paesi che hanno introdotto campagne d’informazione verso i cittadini, ma ancora di più verso gli studenti. Campagne che si sviluppano con poster informativi, lezioni a scuola, e interi capitoli dei manuali per le emergenze che mettono in evidenza come la disinformazione sia a sua volta una grossa problematica da affrontare, e non qualcosa di cui sorridere. Pensate: in Svezia già nel 2018 si metteva in guardia la popolazione dai rischi legati alla disinformazione durante la campagna elettorale. In Italia solo a fine 2025 il nostro ministro della Difesa ha ammesso che siamo da anni in una guerra ibrida che in parte abbiamo brutalmente perso, dopodiché la questione pare essere morta lì.
Nel nostro Paese l’alfabetizzazione contro la disinformazione è spesso affidata alla buona volontà di singoli insegnanti o a progetti sporadici che durano lo spazio di una stagione. Raramente viene considerata una priorità. Eppure, come ben sa chi legge BUTAC, viviamo in un’epoca in cui attacchi informatici, propaganda e campagne disinformative sono strumenti geopolitici concreti.
Prepararsi significa anche questo: rendere i cittadini meno vulnerabili alla manipolazione. La preparazione civile non è solo preparare uno zaino e tenerlo sempre sottomano. È consapevolezza, cultura, responsabilità condivisa. E forse, prima dei kit di emergenza, è questo il passo culturale che in Italia fatichiamo ancora a fare.
maicolengel at butac punto it (ma completamente ispirato dalla mail a cui faccio riferimento)
Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!
Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.
BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti.